
ABITARE IL LAVORO
di Francesca Liliana Maggiora
Mi capita sempre. In ogni casa che ristrutturo. Ad un certo punto arriva il momento del saluto.
L’artista Ila Bêka paragona l’architettura a dei figli..che sai che devi lasciare, sapendo che c’è stato un momento in cui hai prestato loro tutta la tua attenzione, ma consapevole anche che arriverà il momento della separazione. Perché non sono solo più “tuoi” e forse, in realtà, non lo sono mai stati. Il tuo è un servizio che presti per qualcosa che va oltre te.
Ogni volta che inizio un progetto, c’è una prima fase, fondamentale: la conoscenza. La conoscenza dei luoghi, della storia e delle donne e degli uomini che andranno ad abitare quel luogo che, a breve, prenderà forma e vita. Il progetto non può che essere partecipato: cambia con le persone che lo abitano, cambia con il momento in cui queste persone lo vivono e deve essere aperto alle trasformazioni. La casa si trasformerà grazie ai suoi abitanti ed io, progettista, divento promotore di questo cambiamento.
Non condivido l’idea della casa come scenografia, come luogo in cui le persone si “muovono”. L’essere umano è in continuo cambiamento ed è diverso per emozioni, tempo, luoghi, culture.. E così deve essere l’architettura: studiata e preparata ad essere “altro” rispetto a quello per cui tu, progettista, l’avevi pensata.
Concordo con Ila Bêka sul fatto che il ruolo dell’architetto consta di un momento di progetto e poi di un altro momento “di guardia”. Ai miei committenti, che sono donne e uomini, anziani e bambini, dico sempre che sono un “cane da guardia”. E loro ridono e ne rido anche io. Perché in fondo mi piace l’immagine.
Ritornando in case da me progettate e seguite, diventate altro col tempo e con le persone, mi sento in qualche modo in un porto sicuro. E allora mi capita di muovermi in quegli spazi come fossero anche un po’ miei, con una libertà che non avrei in altre case. Mi guardo intorno e so cosa ci sta dietro a tutto quello che vedo, so come sono stati costruiti quegli spazi, quali sono le piastrelle che ho fatto rimuovere perché non mi piacevano come posate; conosco la soluzione che ho dovuto trovare in pochi minuti per risolvere un problema.
E’ strano: perché per un periodo della mia vita quella casa, quel quartiere è diventato anche un po’ mio. Conosco il panettiere, il barista che prepara i caffè. La portinaia mi racconta dei problemi che ci sono in casa, il transgender dell’angolo mi dice del freddo che ha in inverno. I bambini escono da scuola, alcune persone si riparano dalla pioggia sotto il “nostro” portone.
Conosco dove andare a parcheggiare per trovare posto, dove c’è il primo negozio vicino di materiale elettrico, idraulico, il più vicino magazzino edile, il primo colorificio.
Nei differenti quartieri della città so che ci sono persone che mi hanno visto nei miei momenti bui, in cui non alzavo gli occhi da sotto il cappello e poi in quelli in cui ero carica di entusiasmo. Ci sono persone che hanno visto la mia stanchezza alla fine del cantiere. Stanca ma felice, si dice. Così mi sento ogni volta. So che dovrei mettere dei limiti, che non posso, ogni volta, ridurmi a non avere la voglia di parlare con nessuno.. perché d’inverno in cantiere fa troppo freddo e d’estate fa troppo caldo..
Comunque, ad un certo punto, la separazione arriva. E quelle strade non le percorro più e quelle persone che hanno fatto parte della mio quotidiano per un periodo di tempo definito, non ci sono più. Così, semplicemente, ce ne sono altre.
Dopo 15 anni di architetto non so ancora prevedere e prepararmi per tempo al distacco da tutto questo. E forse va bene così, perché tutto farà sempre parte di me.

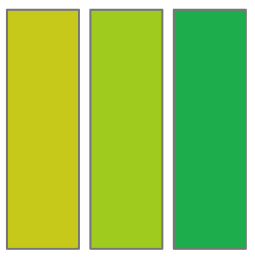
Commenti recenti